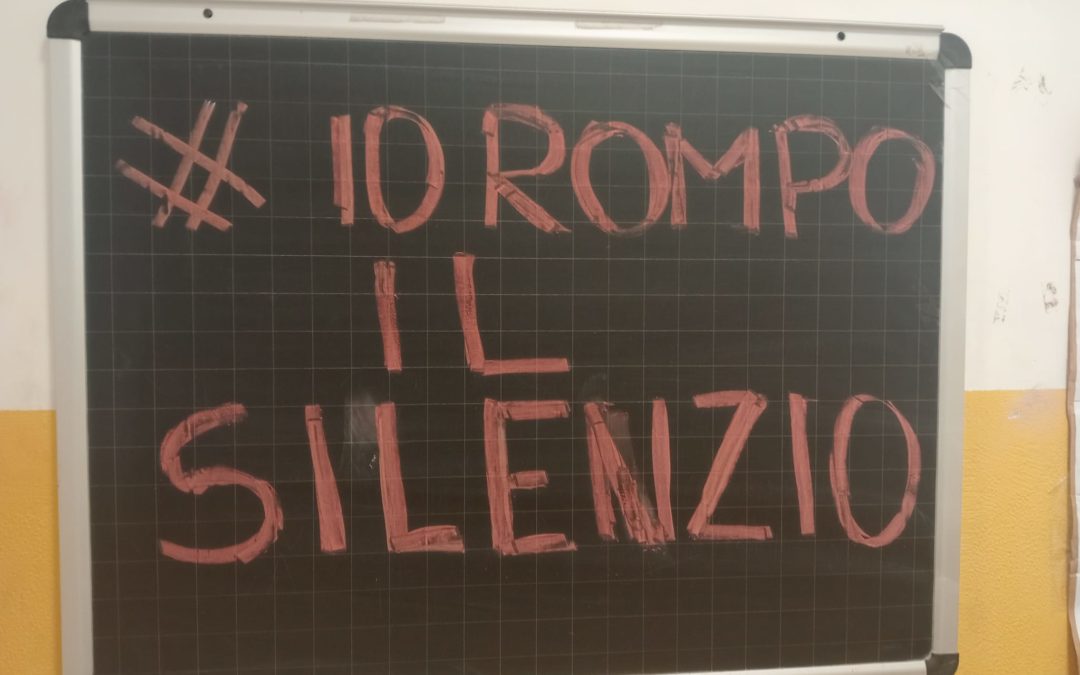Studiare o lavorare. Sull’alternanza scuola-lavoro
di Lorena Currarini da http://www.leparoleelecose.it

La legge 107/2015 introduce l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro con questa formulazione: «l’alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo (…), che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche sul mercato del lavoro (…)».
Si prevede che ogni allievo del triennio di liceo affronti per circa 70 ore nell’arco di ogni anno scolastico un’esperienza di lavoro, ‘sistematicamente’ in armonia con l’offerta formativa della scuola frequentata. Per i tecnici e i professionali le ore raddoppiano: quattrocento, circa centrotrenta l’anno. Un’eternità. Questa parte della legge ha cominciato a dispiegare i suoi effetti nell’anno scolastico 15/16 e in questo, rivelando nella pratica quotidiana di funzionare anche peggio di quanto si poteva immaginare.
1. Il lavoro non c’è
La formulazione è tanto vaga quanto velleitaria. Cosa significa esattamente ‘alternanza scuola lavoro’ non l’ha precisato nessuno. Certo non la legge, che si limita a imporla. Lo scorso anno scolastico le scuole hanno letteralmente inventato le forme con cui assolvere l’obbligo di legge, ricorrendo a soluzioni fantasiose e improvvisate, o delegando il tutto agli studenti, andate e fate. L’assunto implicito è che i ragazzi abbiano bisogno di un bagno di realtà. Basta con tutte quelle ore in classe, diamo un taglio a tutti quei discorsi di cui vi riempiono la testa, andate a lavorare. Preoccupa un po’ che il ministero dell’istruzione consideri l’istruzione una specie di orpello e ritenga necessario rimediare iniettando robuste dosi di sana concretezza produttiva.
A proposito di mondo reale: il lavoro non c’è. Senz’altro in qualche parte d’Italia esiste qualche distretto industriale particolarmente fortunato che fa eccezione; ma in genere l’offerta di lavoro latita. Non ci sono fabbriche (chiudono, delocalizzano, licenziano, mettono in cassa integrazione); le piccole aziende hanno altro da fare che accogliere frotte di adolescenti ruzzanti nei corridoi; le istituzioni pubbliche – biblioteche, centri di documentazione e di studio, musei, uffici di varia natura e dimensione, del comune, dell’ex provincia eccetera – hanno capacità limitata. Un liceo medio con una popolazione scolastica di un migliaio di studenti dovrebbe collocarne circa seicento: che per settanta ore l’uno producono una quantità spaventosa di ore-lavoro da smaltire, in sorda lotta con gli altri licei e anche con gli istituti tecnici e professionali, oberati dalla doppia razione di ore da sistemare. Migliaia di ragazzi in cerca di impiego gravitanti su uno stesso territorio. Dove li mettiamo? Mistero.
Il lavoro che vanno a svolgere ovviamente non è in linea con la formazione offerta dalla scuola come prescrive la legge (ma un legislatore dovrebbe sapere in quale paese vive). E’ già tanto che lo trovino. La legge comunque, generica com’è, permette tutto. Una volta sistemati alla meno peggio in qualche volenteroso ufficio o istituzione, a questi ragazzi non si sa bene cosa far fare. Fotocopie, in genere. Oppure vanno a fare i facchini (scaricare casse nel negozio di qualche amico di famiglia è una soluzione molto praticata); o i commessi da McDonald’s (né fantascienza né mia malizia: convenzione firmata dal Miur).
Intendiamoci: nulla di disonorevole nello studente che fa il facchino. Nessuno snobismo né compianto sul ragazzetto perbene che deve piegarsi a mansioni sottoproletarie. Può essere molto importante, per lui. Purché sia pagato; lo faccia d’estate per raggranellare qualche soldo, riceva il giusto salario, e sarà un’esperienza sommamente formativa. Che lo faccia gratis per volontà dello stato mi sembra un progetto educativo un po’ meno comprensibile. Molto chiaro per quanto riguarda i vantaggi delle aziende: ma qui stiamo parlando di scuola, non di abbassare il costo del lavoro.
Nel caso si faccia loro fare qualcosa di facile ma utile, magari caricare dati in una segreteria comunale o scolastica o di biblioteca eccetera, quello che succede davvero è che svolgono gratis mansioni che dovrebbero essere pagate a dei lavoratori adulti. In pratica, rubano il lavoro ai loro fratelli maggiori o ai loro padri
2. La scuola-lavoro fagocita la scuola-scuola
L’alternanza verrà valutata. E’ diventata una materia importante, ha un monte ore che eguaglia o supera quello di moltissime altre discipline (storia, arte, filosofia, fisica, scienze, per esempio). E’ evidente che si tratta del cuore di una riforma che si vuole (ed è) radicale. Non si limita a tagliare le ore, come d’uso fin qui. Entra direttamente nella logica della formazione culturale e la modifica. Infatti, viene abbondantemente finanziata: l’insegnante che si occuperà di tenere i contatti ‘col territorio’ riceverà adeguati compensi.
Si rinsaldano certezze sconfortanti: quell’imperativo di riduzione del debito pubblico che imponeva di ridurre all’osso certi insegnamenti ora impallidisce e si dissolve. Non è un caso che il tempo scuola-lavoro lambisca e attacchi il tempo della scuola vera. Le ore obbligatorie sono troppe per riservarle interamente al pomeriggio o all’estate. Materie già decurtate devono cederle ulteriore tempo. Nella mia scuola, ben due settimane di letteratura italiana sono dedicate alla preparazione del curriculum e al colloquio di lavoro. Non è irrilevante, quante ore si cedono. Anzitutto sul piano simbolico: sottrarre preziose ore di lezione alle esigenze dell’alternanza significa riconoscerne la superiorità e l’urgenza formativa.
E’ una perdita secca sul piano culturale. Svolgere un lavoro serio, a scuola, richiede tempo. Tempo per spiegare, ascoltare, discutere, parlare e far parlare., scrivere e correggere. E’ uno scambio brutale: spiegando che al colloquio di lavoro non si va in ciabatte rinuncio per esempio alla digressione sul melodramma barocco, o alla pagina di Un anno sull’altipiano in cui Lussu scopre all’improvviso che l’ufficiale austriaco di là dalla trincea è solo un uomo che sta prendendo il caffè. Semplicemente, rinuncio a fare scuola, cioè a regalare domande e dubbi, o storie e parole che difficilmente avrebbero potuto trovare da sé.
Al suo posto, devo proporre la visione del mondo del selezionatore aziendale. Ho scoperto per esempio con un certo sgomento che nel curriculum è bene presentare anche il lavoro nero svolto, perché, spiegava radiosa la relatrice TQ, ‘fa competenze’, e ‘qui le questioni etiche non c’entrano’. Ragazzi già per proprio conto molto tentati dal cinismo italico troveranno qui la conferma autorevole (viene dalla scuola stessa!) che nel mondo reale tutti aggirare la legge non è reato.
3. Chi valuta cosa?
L’alternanza modifica la logica della formazione scolastica in modo così potente e esplicito da riplasmare lo stesso esame di stato. Il colloquio si aprirà con il resoconto dell’esperienza scuola-lavoro. Di nuovo, i simboli contano: cominciare l’esame con questo argomento significa porlo al centro del percorso scolastico, farne il fine ultimo, il culmine, il telos. Non si esamina ciò che il ragazzo ha imparato, ma ciò che ha fatto. Anzi, in maniera più sottile e pericolosa, ciò che lui è.
L’esperienza del lavoro, infatti, secondo la legge (e secondo il suo ispiratore palese, la Carta di Lisbona del 2000) deve potenziare le abilità trasversali, o competenze. Un nodo su cui forse l’insegnante medio non ha ancora riflettuto a sufficienza, ma che rappresenta il nucleo generatore della trasformazione a cui passo dopo passo stiamo assistendo. Il profilo educativo (culturale non è più un termine utilizzabile, in questa logica) proposto dalle ‘competenze’ è così vacuo che ci si accorgerà ben presto che non c’è nemmeno bisogno della scuola per formarle: i ragazzi le sviluppano allo stesso modo, anzi meglio, quando si organizzano per andare a un concerto o fare un viaggio o cercare un posto sicuro dove far l’amore con la fidanzata. Capacità di organizzazione, rapida risoluzione di problemi contingenti, inventiva, anche una certa dose di faccia tosta… Mica c’era bisogno di allestire la macchina farraginosa dell’alternanza.
Competenze, abilità trasversali, soft skills, imprenditorialità sono termini in larga parte intercambiabili, che indicano la torsione radicale cui è sottoposta la formazione. Da una scuola che forma cittadini, sulla base di un progetto culturale condiviso a livello nazionale (i programmi, che creano una memoria comune, un patrimonio collettivo) a una scuola che deve produrre persone di un certo tipo, potenziando ‘la capacità di comunicare, lavorare in gruppo, mobilitare le proprie risorse per far fronte a problemi contingenti’, eccetera. Doti, sembra, richiestissime dal mercato del lavoro: dunque – dunque? da quando questa conseguenza è così ovvia? – la scuola le deve fornire. Non con la letteratura – questo verboso ferrovecchio; più in generale, non con i contenuti, che sono – si legge chiaramente fra le righe della Carta – più che altro un impaccio. Utili tutt’al più come materiale grezzo da cui partire per sviluppare ciò che conta davvero. Quindi, riducibili a piacere, ritagliabili, comprimibili, semplificabili, ignorabili, anche un po’ disprezzabili (vecchi, noiosi, inutili): sono solo schemi intercambiabili su cui lavorare, non hanno importanza in sé. Ci vuole un altro tipo di addestramento al mercato. Meno contenuti e più lavoro.
Il lavoro presenta il vantaggio di mettere in luce il fine supremo della formazione, cui è dedicato un intero punto (il numero sette) della Carta di Lisbona: l”imprenditorialità. Il disagio che sento di fronte alla questione dell’imprenditorialità deriva dalle sue molte ambiguità. Così come le soft skills, cui è legata a doppio filo (da un’impostazione ideologica aziendalista fin dalle sue radici, visto che si tratta di concetti nati in ambito industriale), mi sembra una dote legata più al carattere individuale della persona che non a ciò che si apprende a scuola. Non credo sia possibile addestrare all’imprenditorialità. Non è una tecnica, non è una disciplina: è un’attitudine della persona, un tratto del carattere, una dote in gran parte innata.
Vorrei capire perché la scuola debba valutare il carattere di un ragazzo. Con quale legittimità, anzitutto. E poi con quale fine. Quando io valuto uno studente, controllo che abbia appreso e compreso (sì, compreso, fatto proprio, ripensato: non è vero che si chiede la mera ripetizione) contenuti che io gli ho insegnato. Banale, forse, ma misurabile con un accettabile grado di plausibilità e oggettività. Cosa valuto esattamente, quando valuto l’imprenditorialità o le abilità trasversali? Premio o punisco qualcosa che appartiene all’ambito delle sue doti personali – la disinvoltura, l’estroversione, l’originalità, la creatività… Cose belle e giuste, ma è come se dessi nove a quello alto uno e novanta biondo e figo, e quattro a quello che sembra un ragnetto occhialuto. Mi pare poco educativo. E poi vorrei sapere con quali parametri valuterei. Il profitto magicamente generato da talenti finalmente svincolati dagli impacci delle materie scolastiche e liberi di volare nel cielo di Steve Jobs? Le innumerevoli garrule start-up germinate in un tripudio di vitalità creativa dall’esperienza della scuola lavoro? Nel mondo di Barbie, forse: certo non in questo.
Vorrei anche capire cosa facciamo di chi non mostra sufficienti doti imprenditoriali. Mettiamo che uno sia vocato ad altro: che so, la filologia classica. Un topino da biblioteca perso fra le nuvole, come da stereotipo. O un fricchettoncino generoso, genio della matematica, che invece di vendere i suoi appunti li regala. Errore grave: dov’è il suo spirito imprenditoriale? E’ come se la mancata imprenditorialità fosse già pronta a trasformarsi in colpa morale e comportamento antisociale. Non è da tutti inventare, creare, innovare. Certo chi sa farlo potrà vendersi assai bene sul mercato: ma da quando la scuola giudica col metro darwinista del selezionatore del personale? Non eravamo una zona franca, almeno noi? Non contavano altri valori, dalle nostre parti?
La mescolanza fra la questione del lavoro e il voto dell’esame di stato potrebbe quindi generare meccanismi potenzialmente pericolosi. Chi valuta cosa? I ragazzi avranno lavorato (gratis, non dimentichiamolo: è per il loro bene, dice la legge) per esempio da Zara, o come facchini, o chissà dove. Cosa avranno imparato, esattamente? Avranno ricevuto informazioni e direttive su come comportarsi coi clienti, o come disporre magliette su un bancone. Saranno valutati dall’azienda in base al loro rendimento ‘professionale’. Probabile che Zara – nella persona del suo capo giovane e, immaginiamo, entusiasticamente devoto alla causa – valuti molto positivamente la disponibilità del ragazzino a obbedire, per esempio; o, detta spiccia, a farsi sfruttare. Senz’altro apprezzabile da un datore di lavoro. Forse meno apprezzabile sul piano della normale educazione civica, ma questo al ministero sembra sfuggire.
Pare piuttosto dubbia la compatibilità fra il tipo di prestazione che avranno fornito in un negozio di Zara, accompagnata dal giudizio del capo del personale, e il tipo di valutazione che la scuola è tenuta a dare sull’intero percorso liceale dell’allievo. Non è chiaro come sia possibile armonizzare elementi così palesemente eterogenei, radicalmente diversi per natura e scopo. Temo la possibilità di una sopravvalutazione del percorso lavorativo rispetto a quello scolastico; temo l’ingerenza di elementi completamente estranei alla scuola (il capetto di Zara, appunto) nella determinazione del voto finale. Temo che la centralità della formazione al lavoro si riverberi anche sull’esito finale, fagocitandolo, relegando in secondo piano la formazione culturale.

Co.bas. Scuola
Via Monsignor Fortin 44 – Padova
Email: [email protected]
Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)
I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.