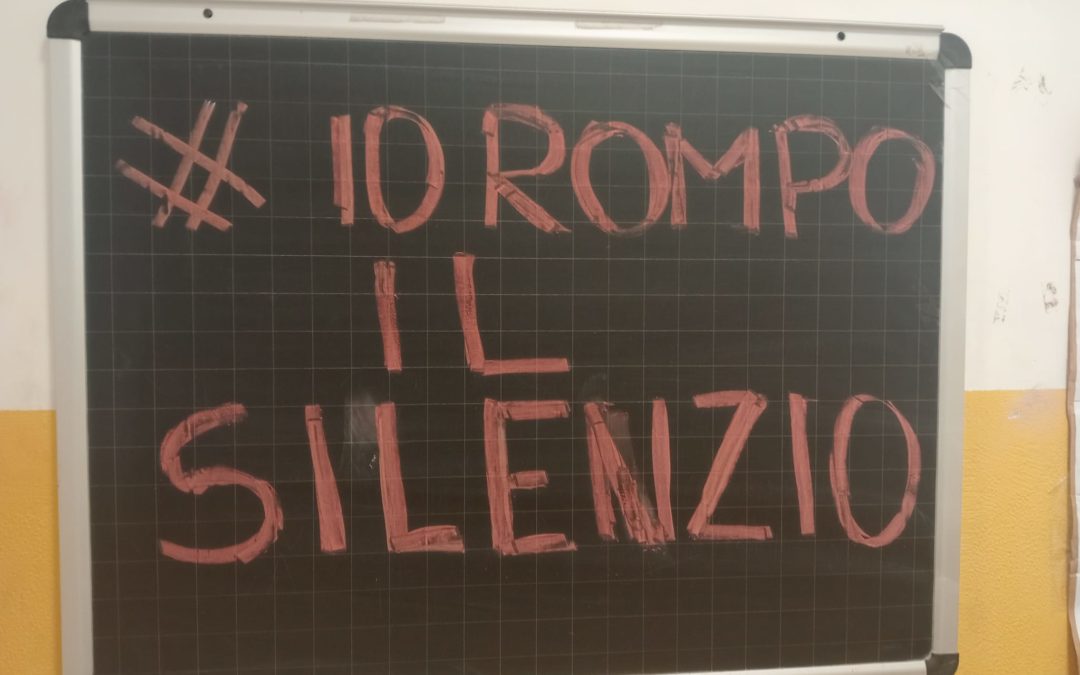La fine della scuola democratica
di Adolfo Scotto di Luzio da vivalascuola
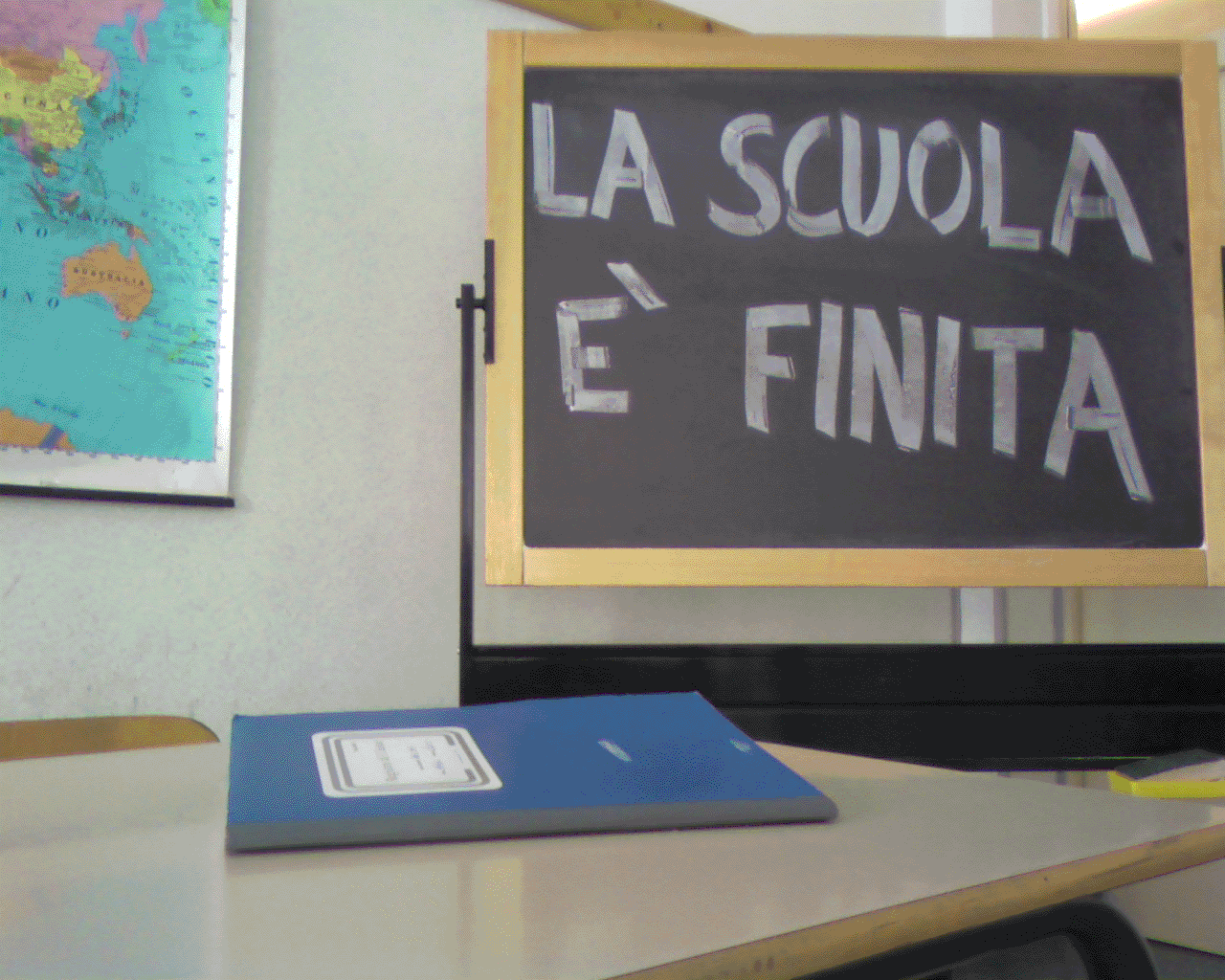
Di cosa parlano i pedagogisti e, soprattutto, hanno ancora qualcosa da dire sull’educazione? Se prendiamo la scuola, gran parte della loro riflessione riguarda questioni come la valutazione, le metodologie didattiche, il tema delle competenze e della loro acquisizione. Tutti argomenti molto tecnici, trattati spesso con un linguaggio astruso, ai limiti dell’ incomunicabile, e che allude ad una comprensione della scuola come macchina da far funzionare. Insomma, i pedagogisti appaiono molto impegnati sul fronte della gestione, ma il senso generale di questa istituzione così centrale nel processo di costruzione dell’Italia moderna sembra essere completamente scomparso dall’orizzonte dei loro interessi. Con quali conseguenze per la scuola stessa? E, soprattutto, per la scuola democratica, che tanta parte ha avuto nella crescita italiana dopo la fine della seconda guerra mondiale?
Se ne discutiamo oggi è perché non solo la crisi di questa istituzione è sotto gli occhi di tutti ma perché, sotto la permanenza intatta di certe formule, come appunto quella della «scuola democratica», in realtà da qualche tempo abbiamo intrapreso senza dircelo un percorso diverso, che ci sta portando fuori dal suo perimetro. In direzione di un apparato altamente burocratizzato che si giustifica sulla base non più della qualificazione culturale dell’individuo ma delle tecniche per il trattamento di una moltitudine sommariamente scolarizzata. La mia tesi è che la scuola democratica sia oggi in crisi non perché si sia esaurita la sua funzione, ma perché si sono esaurite le fonti culturali che l’hanno alimentata lungo tutto il Novecento, dai dibattiti di inizio secolo fino, grosso modo, agli anni Settanta. Oggi queste fonti si sono inaridite e chiedono di essere ripensate.
L’alfabeto che libera
Qualche anno fa sono stato ospite di un’associazione di donne, le «Argonaute», che a Sondrio presentava, nella forma di un video-racconto, i risultati di una piccola ricerca sulle maestre della Valtellina e della Valchiavenna tra anni Quaranta e Cinquanta. Erano storie di giovani donne che, spesso non ancora ventenni, si erano incamminate lungo strade impervie per raggiungere sperdute frazioni di montagna dove avrebbero fatto lezione a bambini delle età più diverse, nelle cosiddette pluriclassi, in un’atmosfera tutt’altro che accogliente, carica di sospetti e di diffidenza. Erano giovani, sole, lontane da casa, esposte perciò agli sguardi e alla maldicenza dei paesani. Vivevano in stanze di fortuna, prive di acqua corrente, a mala pena riscaldate da stufe a legna. Insegnavano a leggere e a scrivere a piccoli montanari che parlavano solo il dialetto e si portavano addosso tutti i segni della povertà e della deprivazione.
L’itinerario di queste maestre stava ancora tutto dentro una geografia dell’alfabetizzazione che era stata disegnata nel corso dei primi anni Dieci, codificata nel decennio successivo, e sulla quale, auspice la lezione di Giuseppe Lombardo Radice, si sarebbe sviluppata la problematica tipica della scuola democratica dopo la seconda guerra mondiale: il tema, e meglio sarebbe dire il mito, dell’Italia contadina.
La campagna, aveva scritto il pedagogista siciliano fin dal 1927, doveva essere considerata come l’«ambiente naturale del ragazzo», capace di un’azione «rasserenatrice» massima sul suo animo, riserva inesauribile di svaghi e di lavori per la natura «primitiva» del fanciullo, di cui eccitava «l’inventività», nonché fonte di studi, in quanto stimolava in lui il gusto dell’osservazione personale e della scoperta. In questo consisteva uno dei caratteri essenziali delle «scuole nuove» secondo l’allievo e collaboratore di Giovanni Gentile alla riforma dell’istruzione elementare nel 1923.
Intorno a questo asse si sarebbe organizzata una parte cospicua della pedagogia militante, laica e di sinistra, del secondo dopoguerra che trova sicuramente nel nome di Mario Lodi la sua versione più divulgata (ma che ha nell’esperienza di Giuseppe Tamagnini le sue prove più meditate) e sarebbero avvenute molte «scoperte», da Don Milani a Paulo Freire, letti entrambi in chiave prevalentemente emancipativo-liberatoria.
Ma il tema del popolo e della necessità di raggiungerlo aveva ricevuto attenzione anche da altre prospettive. Nel grande crogiolo della polemica anti-gentiliana era maturato ad esempio, nel corso degli anni Trenta, l’interesse di Luigi Volpicelli per la pedagogia sovietica e per il tentativo dei bolscevichi di impiantare una scuola di massa su larga scala condotto fin dal 1918. Dalla riflessione volpicelliana vengono non solo il tentativo bottaiano della scuola media unica, ma tutta la tematica, che ne accompagna l’ideazione, della scuola del lavoro.
Alla lezione di Volpicelli riporta un’ altra figura centrale nella cultura magistrale degli anni Sessanta, quella di Alberto Manzi, che di Volpicelli fu allievo e collaboratore nei primissimi anni Cinquanta. Noto ai più per la trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi, nata dall’idea dell’ennesimo «pedagogista» degli anni Trenta, legato ancora una volta al laboratorio politico ideologico di Giuseppe Bottai, Nazareno Padellaro, direttore tra il 1939 e il 1943 della rivista «Tempo di scuola», anche Manzi non resistette all’attrazione contadina, proiettata nel suo caso su uno scenario più vasto. Partito, con una borsa di studio dell’università di Ginevra nel 1955, per una ricerca sulle formiche dell’Amazzonia, come avrebbe ricordato più tardi, Manzi vi scoprì molto di più: la condizione delle popolazioni indigene, il loro sfruttamento, la necessità di liberarle per mezzo dell’alfabeto. Ne sarebbero derivati, grazie soprattutto all’aiuto fornito in loco dagli Scolopi, una lunga serie di viaggi latino americani, fino almeno alla seconda metà degli anni Settanta, vere e proprie spedizioni educative, quattro romanzi e, nel 1987, un ciclo di lezioni ai docenti universitari che avrebbero dovuto lavorare al Piano nazionale di alfabetizzazione del governo argentino. Bastano questi pochi cenni per capire che ci troviamo su di un terreno ideologico complesso e ambiguo, sospeso tra teologia della liberazione, guevarismo e peronismo.
Su questo terreno, pure molto italiano, dominato dall’idea di popolo, si incontrano le correnti laiche e cattoliche della pedagogia della seconda metà del Novecento e avviene la prima ricezione tanto di John Dewey che della pedagogia di Lev Vygotskij.
La pedagogia ancella della politica
Tuttavia questo terreno non regge alle scosse degli anni Sessanta e Settanta. L’avvento della scuola di massa manda in soffitta l’intera tematica contadina del secondo dopoguerra. La nuova Italia che emerge dalle imponenti trasformazioni del periodo non ha più nel mondo rurale un referente sociale concreto. Al più, i contadini forniscono al nuovo immaginario pedagogico le figure rimpiante di un mondo sociale compatto, vagheggiato nella forma di quella che Michelangelo Pira ha definito la «bottega familiare» (La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna, Milano 1978): spazio dell’ integrazione di conoscenze e pratiche, sapere e saper fare, di cui la scuola avrebbe dovuto fornire una sorta di riproduzione artificiale, da laboratorio, nel nome dei bambini dei banchi dell’ultima fila prodotti dalla difficile inclusione del nuovo popolo della scuola media nel quadro di un’istruzione prolungata.
È sul terreno di questa scomparsa storica e della conseguente reinvenzione culturale del mondo contadino che si producono alcuni fenomeni significativi di quegli anni come l’ infatuazione per l’esperienza di Barbiana e il successo di Mario Lodi, di cui pochi avevano letto il primo libro, C’è speranza se questo accade al Vho, mentre Il paese sbagliato, pubblicato non più dalle edizioni dell’Avanti ma da Einaudi, vince il premio Viareggio nel 1971 e diviene a modo suo un classico del decennio.
I problemi posti dalla scolarizzazione del nuovo popolo, in una società che conosce ormai elevati tassi di urbanizzazione, chiedono soluzioni di tipo diverso e si rivolgono ad altre fonti. Sono questi gli anni della ricollocazione della pedagogia italiana sul terreno della ricerca americana nel nome, in modo particolare, di Jerome Bruner. Programmazione, organizzazione curricolare, mastery learning, sono alcune delle chiavi del periodo e ne traducono le ambizioni e le speranze.
Mentre la pedagogia precedente si era costruita sulla base di una qualche interpretazione della storia d’Italia, le nuove concezioni rispondono prevalentemente alla richiesta di organizzare nella maniera più efficiente il servizio educativo per un destinatario sociale sostanzialmente nuovo. Esigenze di questo tipo non erano certo mancate fin dalla seconda metà degli anni Quaranta, ad esempio nell’elaborazione della riforma Gonella, ma è altrettanto evidente che solo dopo l’impianto della scuola media unificata, a metà degli anni Sessanta, esse assumono un pieno rilievo. Si determina a partire da qui una frattura che maturerà nel corso degli ultimi vent’anni del Novecento tra «mondo della scuola» e cultura nazionale.
La scuola impara a pensarsi come se fosse completamente staccata dal contesto storico dal quale è sorta, mero servizio educativo della comunità, surrogando il legame perduto per mezzo della nozione, vuota di contenuto, di territorio: di fatto, uno spazio negoziale di mediazione e composizione di interessi sociali disparati, identificabile in termini puramente formali. Dal canto suo, la pedagogia si vedrà relegata in una posizione sempre più irrilevante, persa dentro vaniloqui che non interessano a nessuno, accettando come un’ancora di salvezza il ruolo che le verrà offerto, tra anni Novanta e Duemila, di disciplina di rincalzo di scelte politiche compiute nel nome di esigenze gestionali progressivamente sbarazzatesi di qualsiasi preoccupazione di legittimazione. Dentro questo scambio, la scuola finirà per essere completamente abbandonata a queste esigenze, consegnata senza più mediazioni alla pretesa della politica di modificarla a proprio piacimento. Su questa strada si arriva dritti alla Buona scuola del governo Renzi.
L’autonomia come ideologia della scuola dell’ultimo quarto del Novecento agisce come ulteriore fattore di appro-fondimento della frattura con il mondo vitale della tradizione culturale italiana. Di questa frattura è un’espressione e un sintomo sul piano della coscienza educativa la progressiva autonomizzazione della didattica come sapere tecnico scientifico. La nascita della didattica come «scienza» indipendente porta ad enfatizzare la pratica professionale come forma di conoscenza produttiva. Di qui il profluvio di studi sui cosiddetti saperi magistrali che nel dare rilievo al presunto professionista dell’ insegnamento finiscono per separare ulteriormente il mondo della scuola dal tessuto vivo del discorso pubblico, autorizzando l’ulteriore ripiegamento su se stesso dell’universo scolastico.
L’insegnante “a disposizione“
Ad uno sguardo retrospettivo appare evidente, a chi ha occhi per guardare, il riflesso difensivo e tuttavia vano di questa scelta. Il passaggio dal ventesimo al ventunesimo secolo è segnato da una evidente crisi di legittimazione dei processi formativi. Arrogandosi il possesso di un sapere esoterico, come sono tutti i saperi professionali, in una fase tra l’altro segnata da una marcata perdita di rilievo del professionismo a qualsiasi livello, il mondo della scuola e i suoi ideologi pensano in questo modo di guadagnare una posizione stabile al riparo dalle scosse più impetuose della trasformazione. Ma il professionismo non può niente contro la prepotente riaffermazione del controllo politico sul sistema di istruzione. Dalla metà degli anni Novanta in poi, la scuola è l’oggetto e non certo la protagonista dei numerosi interventi riformatori che ne ridisegnano radicalmente il profilo. L’autonomia del professionista, che il sapere docente dovrebbe preservare, viene così, derisoriamente, mandata al diavolo con i nuovi modelli di gestione del personale che si affermano insieme al nuovo secolo e per mezzo dell’ausilio delle tecnologie informatiche, a partire da quell’organico funzionale, grande conquista dell’autonomia scolastica, che ribadisce la subalternità dell’insegnante, «a disposizione» ora dell’offerta formativa.
Questa scuola si chiama ancora democratica. Per alcuni anzi rappresenta il punto più alto in un compiuto processo di democratizzazione che solo oggi giungerebbe finalmente a compimento, nel segno di una piena affermazione della persona e dei suoi diritti. Della scuola democratica, tuttavia, questa nuova scuola non ha ciò che fu il suo cuore pulsante nella complessa elaborazione primo novecentesca, vale a dire un’idea di popolo, che poi non significa altro che un modo di iscriversi della scuola dentro la storia del Paese e in fondo della sua statualità.
È stato questo, sostanzialmente, il contributo fornito alla elaborazione delle strutture ideali e organizzative della scuola italiana tanto dal liberalismo che dal socialismo tra Ottocento e Novecento. La convinzione giacobina delle élite liberali che, per diventare moderna, l’Italia avrebbe dovuto operare, con tutte le cautele del caso ma con determinazione, il trasferimento dei contadini dalle basi della loro situazione concreta di vita su di un terreno nuovo, rappresentò il programma che nessuna sinistra rivoluzionaria avrebbe pensato di dover abbandonare nel corso del Novecento. Per quanto carico di ambiguità, il tema contadino che segna così profondamente l’esperienza pedagogica degli anni Cinquanta resta sostanzialmente sul terreno dell’emancipazione e solo molto più tardi si irrigidirà nella forma controculturale di un’alternativa, sognata molto più che pensata ad essere onesti, alla società dei consumi.
Da questo punto di vista la crisi della scuola democratica è innanzitutto una crisi ideologica e chiama in causa le strutture ideologiche che presiedono alla riproduzione dei ceti intellettuali intermedi del nostro paese.
L’aspetto più rilevante è che questa scuola che ha imparato a pensarsi su basi completamente nuove, e che affida ormai tutte le sue esigenze di legittimazione ad una retorica dell’innovazione tanto vuota quanto infondata, si trova imprevedibilmente scoperta di fronte al ritorno prepotente della questione che fu alla base del suo sviluppo, quel popolo rimesso drammaticamente in gioco nella sfida dell’ immigrazione.
Non saranno un computer o un insegnante di sostegno a fornire la soluzione
Solo perché accettiamo supinamente di pensare la presenza del nuovo soggetto immigrato come un problema di integrazione possiamo non rendercene conto. Ma la patologizzazione del conflitto sociale, di cui l’immigrato è portatore, e la sua comprensione sotto l’etichetta dei bisogni educativi speciali non è altro che una forma di autoaccecamento della coscienza educativa nazionale. Un sintomo della sua totale incapacità di pensare la dimensione pubblica come dimensione politica e dunque di concepire le basi culturali della identificazione del nuovo cittadino, abbandonato invece a mere tecniche di gestione. Ma non saranno un computer o un insegnante di sostegno a fornire la soluzione ad un problema di portata epocale e che ci impegna non semplicemente come comunità ma come nazione, perché della nazione sollecita l’aspetto fondamentale, la capaci-tà cioè di trovare quella misura comune che è la base di qualsiasi solidarietà o, per dirla in maniera meno retorica, della di-stribuzione dei costi e dei benefici tra concittadini.
È evidente che questa solidarietà, o disponibilità che dir si voglia nei confronti del sentimento dell’essere insieme, esige un impegno collettivamente assunto attorno ad una definizione dell’identità comune. Ma per questo la scuola democratica dovrebbe smettere di pensarsi come una metodologia dell’interazione democratica e riprendere i fili di un discorso intorno al contenuto di ciò che insegna.

Co.bas. Scuola
Via Monsignor Fortin 44 – Padova
Email: [email protected]
Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)
I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.